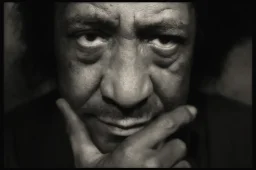La differenza tra lingua e dialetto: il biasimo sociolinguistico che ha caratterizzato la nostra formazione
- Dicembre 23, 2024
- di
- Ida Matarese
“La lingua è un dialetto con esercito e marina”.
È con questa curiosa espressione che il linguista Max Weinreich, nel 1945, si è fatto portavoce di una delle tematiche più interessanti nell’ambito degli studi linguistici: la differenza tra lingua e dialetto.
Fin da bambini, siamo stati abituati a distinguere nettamente questi due concetti, interpretando il secondo come una distorsione della nostra lingua nazionale. Il dialetto sarebbe un qualcosa di rozzo, di fatto male, una forma imperfetta priva di regole grammaticali e di una propria struttura interna.
Che il dialetto sia interpretato come una varietà “socialmente bassa”, profondamente marcata in diastratia, è qualcosa di appurato: c’è una sostanziale differenza tra chi adopera l’italiano come lingua nativa e chi invece un dialetto. Basti pensare al divario che è possibile riscontrare tra il repertorio linguistico di un ministro della Repubblica e quello invece utilizzato da un’anziana casalinga dell’entroterra campano.
Il focus della citazione di Weinreich è proprio questo. La differenza tra lingua e dialetto non è riscontrabile nella loro struttura, bensì nel valore sociale che attribuiamo a queste due varietà.
Gli studi linguistici dimostrano che la tendenza a guardare al dialetto come una forma strutturalmente inferiore altro non è che un biasimo sociolinguistico che ci portiamo dietro da decenni.
Lingua e dialetto, da un punto di vista strutturale, sono in sostanza sullo stesso piano e hanno pari dignità linguistica. Un chiaro esempio di quanto finora affermato ci è fornito proprio dalla storia evolutiva dell’italiano con la sua secolare “questione della lingua”.
L’Italia è probabilmente uno dei paesi al mondo con il più alto tasso di eterogeneità dialettale. Storicamente, tutte queste varietà italoromanze – naturali evoluzioni di quel latino di tradizione popolare, denominato dagli studiosi latino volgare, contrapposto al latino classico, stabile e codificato – hanno da sempre costellato la nostra penisola, caratterizzando la comunicazione quotidiana e spontanea dei suoi abitanti e determinando la grande frammentazione linguistica dello stivale.
Ripercorrere tutte le tappe della storia della lingua italiana richiederebbe troppe pagine, ma si possono riportare quelle fondamentali. Una delle prime testimonianze scritte di quello che, convenzionalmente, è stato chiamato volgare, potrebbe essere l’Indovinello Veronese, un verso rinvenuto ai margini di un codice pergamenaceo e databile tra la fine dell’VIII e l’inizio del IX secolo:
“Se pareba boves, alba pratalia araba, et albo versorio teneba, et negro semen seminaba”.
In realtà, la questione dell’Indovinello Veronese è ancora abbastanza controversa: secondo alcuni, potrebbe rappresentare un possibile atto di nascita del volgare in Italia, altri studiosi invece lo ritengono la semplice realizzazione di una forma corrotta di latino.
Più noto è sicuramente il Placito Capuano del 960, rientrante nei cosiddetti Placiti Cassinesi, che altro non sarebbe che un verbale notarile relativo ad una contesa, discussa dinanzi al giudice Arechisi, tra un proprietario terriero locale e l’abate del monastero di Montecassino circa la proprietà di un appezzamento di terra. L’intero verbale è redatto in latino, lingua dell’alta cultura, ma le dichiarazioni dei testimoni – e questa rappresenta la grande novità – sono riportate in volgare:
“Sao ko kelle terre, per kelli fini que ki contene, trenta anni le possette parte Sancti Benedicti”.
Insomma, è facile rinvenire una forma primordiale di quello che è uno dei tanti dialetti del meridione.
È tra il 1200 e il 1300 che nasce l’esigenza di trovare una lingua comune per la tradizione scrittoria. Gli autori iniziano a cimentarsi nella redazione di opere in volgare, di cui la Commedia, il Rerum Vulgarium Fragmenta e il Decameron rappresentano le punte di diamante.
Lo stesso Dante, nel suo De Vulgari Eloquentia, passa in rassegna i diversi volgari della penisola, alla ricerca di quello “illustre, aulico, curiale, cardinale”: una lingua comune che potesse assurgere al ruolo di lingua letteraria per eccellenza nel «bel paese dove ‘l sì suona».
Nonostante l’Alighieri abbia sistematicamente scartato ciascuno di questi volgari, è noto come il prestigio delle Tre Corone e le circostanze storico-culturali abbiano determinato l’emergere di un particolare volgare, ossia il fiorentino.
Ecco che la lingua di Firenze inizia progressivamente la sua ascesa e diventa l’indiscussa protagonista della secolare “questione della lingua”: si ricorda l’importante contributo di Pietro Bembo con le sue Prose della Volgar Lingua, dove l’autore guarda con favore al fiorentino trecentesco di Petrarca e Boccaccio (Dante viene sistematicamente “bocciato” a causa del forte mistilinguismo della Commedia), passando per l’opera dell’Accademia della Crusca, per l’onomaturgia di Galileo nel linguaggio scientifico, sino a giungere al lavoro di Alessandro Manzoni che, con l’edizione quarantana de I Promessi Sposi e la “risciacquatura in Arno”, propone l’uso vivo della lingua di Firenze.
Ecco come il fiorentino, da semplice volgare, da semplice dialetto, ha conosciuto, nel corso dei secoli, un’elaborazione tale da essere promosso quale lingua nazionale.
È importante sottolineare come, al momento dell’Unità, il popolo italico non possedesse una lingua comune per la comunicazione orale. L’unico elemento comune era rappresentato da una lingua puramente letteraria basata sul fiorentino trecentesco, che aveva attraversato secoli di dispute linguistiche ma che, di fatto, era una lingua “morta”. Nel concreto, la comunicazione verbale avveniva nei tanti dialetti parlati negli altrettanti Stati in cui era suddivisa la penisola.
A questo c’è da aggiungere che, come riportato da Tullio De Mauro, ancora nel 1863 la stragrande maggioranza degli italiani, l’80% circa, era analfabeta e neppure il restante 20% poteva dire di possedere una vera competenza linguistica. Insomma, il numero di italofoni alfabetizzati era drasticamente basso.
Solo grazie alla politica linguistica e a fattori quali l’immigrazione, il lavoro nelle fabbriche, la burocrazia, l’urbanizzazione, la diffusione della stampa e la convivenza forzata nell’esercito si è giunti alla diffusione di quella lingua che, finalmente, può essere definita “italiana”.
Come è possibile costatare, dunque, l’italiano altro non è che un dialetto – il fiorentino – che nel corso dei secoli ha ottenuto un esercito e una marina. Ha, cioè, conosciuto un programma di istituzionalizzazione, passando per quelle operazioni di corpus e status planning necessarie per il suo riconoscimento ufficiale quale lingua di uno stato.
È chiaro come l’unica differenza tra lingua e dialetto sia in realtà di natura sociale e come questa sia legata a doppio filo alla concezione che ne ha la comunità dei parlanti. La lingua italiana risulta dalla promozione di uno dei tanti volgari della nostra penisola e conosce oggi un maggior prestigio sociale in quanto lingua standardizzata e ufficiale.
I dialetti non sono dunque da considerare strutturalmente inferiori, come non devono esserlo tutte quelle varietà che, a primo impatto, possiamo considerare come “fuori norma” perché, da una prospettiva sociolinguistica, queste si fanno portatrici di determinati valori sociali che vengono veicolati attraverso il loro utilizzo.
Lingua e dialetto non hanno dunque differenze strutturali e sostanziali. L’identificazione di una varietà alta ed una varietà bassa è di natura sociale e lo stesso italiano altro non è, come direbbe Gaetano Berruto, che “un dialetto che ha fatto carriera”.