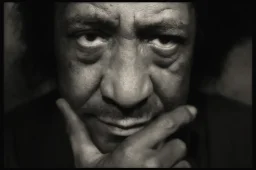Donna, madre e terra: tornare alle radici della società per onorare la figura del femminile
- Aprile 07, 2025
- di
- Matteo Carbone
Anticamente, la connessione fra l’elemento femminile e quello maschile era profonda. Si viveva in perenne contatto con gli elementi e ciò che ci manteneva in vita era inevitabilmente chiaro, vivido e venerato come tale. In quest’ottica distinguere l’essenziale dal superfluo era pratica innata. La madre, il femminile, l’elemento primigenio da cui tutto nasceva era pertanto riconosciuto e venerato anche attraverso nomi specifici e diversi, a seconda dei luoghi e dei tempi. Lo ritroviamo ancora oggi in termini come Pachamama, Gaia, Izanami e Cihuātl, Ixchel1. Era quell’elemento metafisico originario da cui prendevano vita tutte le altre “cose”.
Ebbene contestualizzare oggi il ruolo della “madre” e del femminile, nella società attuale, ovvero una società industriale che parafrasando Gramsci “ha contrapposto alla vecchia cultura umanistica, quella tecnologica frantumando e disgregando la vecchia unità ed esclusività della cultura tradizionale”2, presuppone interrogarsi su come non solo sia considerato il ruolo della donna ma com’è considerato e trattato l’ambiente, da sempre emblema della femminilità.
Significa scendere nel profondo ed analizzare gli effetti manifesti proprio di quel rapporto con l’ambiente che nasce da un’ideologia produttiva spesso fine a sé stessa la quale ha pervaso perfino il senso del vivere. L’ideologia dell’usa e getta, il mettere il profitto avanti ogni cosa, il ripensare i prodotti affinché si rompano a tempo, non può non riflettersi sull’ambiente e alla fine anche su chi lo abita. Questo medesimo rapporto non ha potuto impedire neppure una contaminazione dell’idea stessa che noi abbiamo dell’esistenza, la quale rischia sempre più di esser mercificata come i prodotti di cui ci disfiamo con semplicità.
La velocità e la ripetitività hanno illuso che tutto sia sostituibile e rimpiazzabile; l’immaginario è stato colonizzato dal rinnovarsi di sempre nuovi bisogni e inevitabili “obsolescenze”. Ciò spinge a vivere seguendo moti centrifughi che allontanano inevitabilmente proprio da quel vivere centrato e radicato che può trovarsi solo in una mente calma e consapevole.
Ecco perché interrogarci oggi sul ruolo della donna presuppone interrogarci sulla percezione che noi abbiamo della nostra stessa vita, sulle nostre esigenze e sulla distanza che ci hanno insegnato a porre con “il resto” sia esso l’ambiente o l’altro.
Perfino la violenza di genere potrebbe, in tal senso, essere vista come una cartina tornasole di un problema molto più complesso ed esteso che può trovare cura partendo da una ricerca di senso e armonia perdute. Dove non vi è rispetto per la natura, per le piccole cose e per la parte “accogliente” del mondo vi è perdita di significato e connessione viscerale con il tutto e, a quel punto, non possiamo più stupirci che tale contaminazione possa assumere connotati di aggressione verso un “altro” con cui ci poniamo in eterna lotta. Avere un’idea separata della natura presuppone inevitabilmente averla anche da chi questa natura la abita essere umano e animali compresi. Tutto è connesso; per capirlo basterebbe osservare come oggi si produce ciò che dovrebbe nutrirci e che inevitabilmente finisce con il contaminarci. Se infatti produciamo con la chimica dei veleni e alleviamo con la ferocia e la freddezza dei lager, come possiamo pretendere di esser nutriti e non annichiliti da chi e da ciò che annichiliamo?
Come può una società prospera fondare il proprio sviluppo su un’agricoltura e un allevamento in guerra con l’ambiente? Questo è solamente uno dei punti da cui partire. Nel corso dei secoli varie visioni si sono succedute e chi studia la filosofia, la storia come noi “universitari” ne è a conoscenza.
Abbiamo bisogno di riscoprire i legami che possano colmare lo scollamento tra ciò che è moderno e ciò che è primigenio sanando, ed è possibile farlo, quanto oggi reputiamo insano. Ma dobbiamo riscoprire il valore del femminile anche analizzando in senso critico il nostro rapporto con l’ambiente, la nostra modalità di fare agricoltura, la nostra modalità di intendere il profitto, il nostro modo di vestire, di viaggiare, di “consumare”, studiare e soprattutto pensare, de-finalizzando la cultura dalle sole metriche del profitto fine a se stesso. In questo senso, tornare a studiare con passione, vuol dire tornare a percepire il senso che tutto abbraccia e indipendentemente dalle varie branche dello scibile, permea di significato la vita stessa.
Al contrario, finalizzare lo studio alla mera ricerca di una “occupazione” vuol dire svilirlo e porsi in veste utilitaristica e in modo acritico, al servizio di ogni tipologia di “economia” dimenticando perfino il significato primo di tale termine ovvero la corretta gestione della casa.
Affinché vi sia quindi una rinascita e un ritorno di senso oggi spesso assenti nelle fredde logiche militari, nelle “positive” e distanti imposizioni burocratiche, nelle rigide linee guida dei protocolli del tecnicismo è proprio ad un approccio femminile che dobbiamo guardare.
Abbiamo commesso l’errore di suppore che il progresso potesse essere fine a se stesso indipendentemente dai “riflessi dannosi” che si sono manifestati e si manifestano ancora per mezzo di una generale perdita di equilibrio che noi abbiamo imparato a chiamare “inquinamento”. E cos’è quindi l’inquinamento se non una perdita di senso, se non una perdita di equilibrio e un allontanamento dai cicli naturali oggi tanto cari anche all’economia circolare ai quali essa si ispira? L’economia dei processi e dei cicli che chiamiamo “circolare” oggi finalmente indentifica come scarto una perdita di valore ma soprattutto intende il rifiuto come l’evidenza di una disfunzione e di uno scartamento, guarda caso, proprio tra l’industria e la natura in cui lo scarto non esiste.
Ebbene guardare alla natura con capacità tecniche e conoscenze approfondite non è un ritorno nostalgico al passatismo, né un richiamo ai carri dell’arcadia e nemmeno visione nostalgica ma una presa di coscienza. Tornare alla natura, al rispetto della “madre”, al rispetto del ruolo della donna valorizzandola, dandole voce e spazio affinché essa non debba farsi mascolina per esser “audita” nella fallocentrica società moderna ma sia valorizzata per ciò che è ovvero un contributo indispensabile, fondamentale e insostituibile, è il futuro.
Per farlo non dobbiamo combattere il progresso ma attribuirgli un nuovo senso studiando fin ora in modo critico e cogliendo l’opportunità che ci dà lo studio stesso; orientando la nostra conoscenza al servizio non di una fredda logica ma di una società che ha un bisogno represso e viscerale di donne e uomini pensanti, critici, vivi, liberi e insostituibili.
Questo sarebbe un ottimo modo per onorare la madre, la Dea, la donna e la natura nel giorno della sua ricorrenza: porsi al servizio, interrogandosi su come contribuire a lasciare un’eredità culturale partendo dal ripensare il nostro ruolo futuro nella società; un ruolo che valorizzi innanzitutto noi stessi rendendoci fieri delle nostre scelte indipendentemente “dal mercato” stante l’essere umano, non essere una merce.
E se allora la rinascita della primavera e della donna è celebrata con l’omaggio di una pianta resiliente come la mimosa, che con i suoi fiori meravigliosi dona una esplosione di vitalità, colore e profumo, anche noi possiamo trarre ispirazione e slancio comprendendo il potenziale insito nella conoscenza e immaginare così una moderna società primigenia resiliente e custode, come un tempo, dei beni più preziosi.
1 Fonte https://zeroco2.eco/it/magazine/curiosita/culto-madre-terra/
2 Manacorda, il principio educativo in Gramsci: americanismo e conformismo, Armando, Roma, 1970.